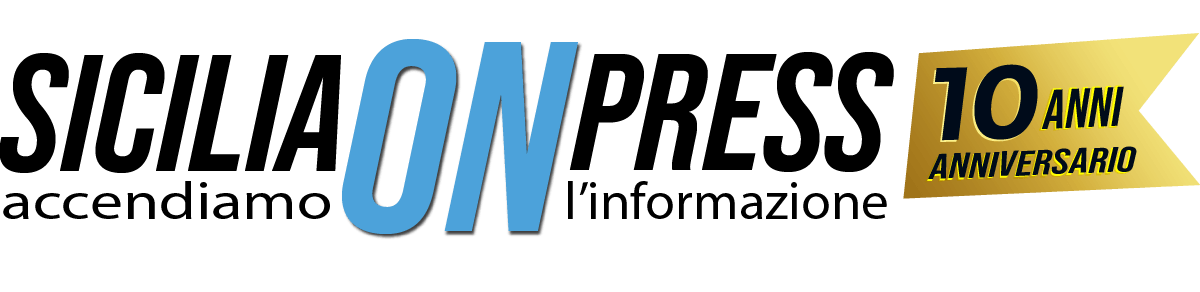Giuseppe Maurizio Piscopo
Felice Cavallaro. Nato a Grotte nel 1949, ha vissuto i primi 5 anni a Racalmuto, il paese di Leonardo Sciascia. E’ l’ideatore della Strada degli Scrittori. Giornalista del Corriere della Sera, segue da quaranta anni fatti e misfatti di mafia. Si è occupato di approfondimenti culturali. E’ stato inviato in America, Tunisia, Irak e in altri luoghi del pianeta. Ha collaborato con il giornale L’Ora, con l’Agenzia Italia e con la Rai. Ha lavorato prima al Giornale di Sicilia e poi al Corriere della sera. Cavallaro ha dato un grande contributo alla cultura italiana. E’ uno dei giornalisti più amati e accreditati di oggi. Spesso la sua presenza è richiesta dalla Rai per comprendere i cambiamenti che avvengono in Italia.
Quando ha iniziato a scrivere?
Il primo articoletto, a otto anni. Lo ricordo bene come fosse ieri. Frequentavo le scuole elementari. Ero arrivato a Palermo a 5 anni. Mio padre era impiegato comunale a Racalmuto, si dimise e si trasferì a Palermo per lavorare nel ‘cinema in casa’, come diceva una mia zia ottuagenaria. Era nata la televisione. Era il 1954. Io stavo spesso con lui e lo seguivo con lo stupore negli occhi mentre andava a realizzare un servizio, mentre aspettava un regista al porto o realizzava una intervista, quando filmava uno sciopero o il crollo di una diga. La sera quelle stesse immagini che avevamo captato insieme, registrate sulla pellicola da 16 millimetri, da via Cerda, allora sede della Rai regionale, venivano riversate in via Teulada a Roma. Oppure si correva a Punta Raisi o a Boccadifalco perché un pilota civile o un militare prendesse in consegna quelle ‘pizze’ trasportandole a Fiumicino o a Ciampino dove un autista della Rai le avrebbe ritirate. Il giorno dopo vedere quelle stesse immagini in tv, al Telegiornale, era un prodigio. Parte da qui il mio interesse per la notizia, per il racconto. Scritto o per immagini. Parte da Emanuele Cavallaro, primo cineoperatore di una Rai che per giornalista e voce ufficiale dell’allora ‘Gazzettino di Sicilia’ aveva Aldo Scimè, mio zio, anche lui approdato a Palermo da Racalmuto. Poi arrivarono tanti altri: il grande Bruno Giordano Zir, il direttore, Luigi Tripisciano, Marcello Bandieramonte, Elmer Jacovino… Io gironzolavo fra loro, quasi come un intruso, ma soddisfatto quando mio padre mi invitava la sera a scrivere la notizia sul fatto visto con i miei occhi. Io provavo. E così riusciva a stimolare la mia curiosità…
Quali sono i suoi ricordi della scuola elementare?
Ho lasciato Racalmuto a 5 anni alla volta di Palermo. La prima elementare al “Boccone del povero”, un convento con uno splendido giardino, un eden, l’istituto di via Cusmano. Tra le mie insegnanti ricordo la bellissima Madre superiora di cui ero innamorato, ma anche una suora con un campanello usato per rimproverare e picchiare. Presi qualche colpo in testa. Forse mi odiava. Due anni dopo per fortuna andai alla Pitrè, una scuola pubblica. Dico per fortuna perché ricordo chiaramente un orrore. Le suore in quegli anni Cinquanta ci facevano vedere dei filmati con indigeni armati di frecce e lance per uccidere i cristiani e calpestare le ostie. E le suore rivolte a noi: ‘Ecco cosa sono i comunisti. Dite ai genitori di votare Democrazia Cristiana e non questi comunisti che, se arrivano al potere, ci strappano il velo’. Un disastro. Quelle stesse suore colpevoli due volte. Di volere manipolare la testa dei bimbi e di tollerare poi il sacco di Palermo. Non potrò mai dimenticare quando, ero già alle medie, vidi distruggere dalle ruspe il convento, quel giardino ricco di frutti con i vialetti fioriti. Al posto di quel paradiso fu costruito un palazzone di 12 piani. Le suore avevano venduto tutto, lasciando costruire di fronte un altro palazzone dove oggi c’è ancora il nuovo “Boccone del povero”. Un’esperienza che mi ha insegnato come ogni storia non possa essere raccontata affettandola, come se tutto fosse o bianco o nero, perché nella vita prevalgono le sfumature, i grigi, le zone grigie. E la verità non è solo quella che appare in superficie. E’ il caso del sacco di Palermo che resta colpa di mafia e malapolitica, spesso tollerato e incoraggiato però da professionisti, nobili e a volte suore.
Il suo percorso giornalistico…
 Da studente ho cominciato a collaborare con il giornale ‘L’Ora’, quando la scrittrice Giuliana Saladino dirigeva la pagina ‘L’Ora scuola’. Scrivevo mentre frequentavo il liceo Cannizzaro. Anni frenetici ed inquieti, pre-Sessantotto. Allora un preside burbero ci impediva di pubblicare un giornale scolastico che si chiamava “Il Ciuco”. Fino ad allora fatto con articoletti banali, barzellette, poesie, resoconti di partitelle di calcio. Noi tentavamo invece di raccontare cosa ci succedeva intorno, di dire che cosa non ci piaceva della scuola, di fare un’analisi della società o della guerra del Vietnam. Allora ascoltavamo le canzoni di Joan Baez e di Gianni Morandi. C’era un ragazzo… Per scrivere queste innocenti riflessioni fummo costretti a fondare “Il Ciuco ombra”, un giornale clandestino. Andammo in tipografia, dal vecchio Priulla, in via Garzilli, ma ci disse che per pubblicare un numero senza firme occorreva un direttore responsabile, così come prevede la legge. E mi presentai in piazzetta Napoli, nella sede de L’Ora, chiedendo di parlare con un giornalista. Dopo mezz’ora fui ricevuto da un cronista che ascoltò con grande attenzione lo sfogo contro quel preside e che alla fine disse: “Sarò io il tuo direttore”. Quel giornalista era Mauro De Mauro, il cronista che la mafia avrebbe fatto sparire nel 1970. Invano il preside tentò di scoprire i responsabili della ‘redazione ombra’. De Mauro ci protesse.
Da studente ho cominciato a collaborare con il giornale ‘L’Ora’, quando la scrittrice Giuliana Saladino dirigeva la pagina ‘L’Ora scuola’. Scrivevo mentre frequentavo il liceo Cannizzaro. Anni frenetici ed inquieti, pre-Sessantotto. Allora un preside burbero ci impediva di pubblicare un giornale scolastico che si chiamava “Il Ciuco”. Fino ad allora fatto con articoletti banali, barzellette, poesie, resoconti di partitelle di calcio. Noi tentavamo invece di raccontare cosa ci succedeva intorno, di dire che cosa non ci piaceva della scuola, di fare un’analisi della società o della guerra del Vietnam. Allora ascoltavamo le canzoni di Joan Baez e di Gianni Morandi. C’era un ragazzo… Per scrivere queste innocenti riflessioni fummo costretti a fondare “Il Ciuco ombra”, un giornale clandestino. Andammo in tipografia, dal vecchio Priulla, in via Garzilli, ma ci disse che per pubblicare un numero senza firme occorreva un direttore responsabile, così come prevede la legge. E mi presentai in piazzetta Napoli, nella sede de L’Ora, chiedendo di parlare con un giornalista. Dopo mezz’ora fui ricevuto da un cronista che ascoltò con grande attenzione lo sfogo contro quel preside e che alla fine disse: “Sarò io il tuo direttore”. Quel giornalista era Mauro De Mauro, il cronista che la mafia avrebbe fatto sparire nel 1970. Invano il preside tentò di scoprire i responsabili della ‘redazione ombra’. De Mauro ci protesse.
E poi?
Prima il diploma, poi la laurea in giurisprudenza. Cominciai a frequentare l’Agenzia Italia grazie al giornalista Piero Fagone, responsabile della sede di Palermo, anche lui nella squadra della Rai e commentatore politico del Giornale di Sicilia. Andavo ogni mattina nella sede di via Emerico Amari con le vetrate sul porto. Ma in sei mesi non mi fece
mai scrivere una riga. Dalle 9 alle 15 del pomeriggio tutti i giorni. Mi sembrava tempo perso. Ma leggevo 7 o 8 giornali diversi. E Fagone mi faceva confrontare la stessa notizia, lo stesso evento su ogni giornale. Leggendo in questo modo dovevo riuscire a trovare una chiave, a immaginare come lo avrei scritto io. Non era tempo perso. Un giorno Fagone mi invitò a seguirlo al Giornale di Sicilia. Il direttore era Roberto Ciuni un grande giornalista. Decisero che dovevo provare e mi affidarono al capocronista, Ettore Serio. Un altro grande maestro. Mi faceva riscrivere gli articoli anche quattro volte. A volte lo odiavo. Poi capii. E diventai la sua ombra. Incuriosito dalla sua tecnica. Nella scrittura e nella catalogazione dei ritagli. I ritagli di giornale. In un’epoca senza computer. Tutto classificato per nome e materia. Un archivio straordinario. Al Giornale di Sicilia ho lavorato per 18 anni. Serio era il corrispondente del Corriere della Sera e quando io cominciai a collaborare facevo il suo vice, firmando gli articoli come “Vice”. Non si aveva diritto nemmeno alla sigla. Allora il direttore del Corriere era Franco Di Bella, poi vennero Alberto Cavallari, Piero Ostellino, Ugo Stille…
Lei è stato inviato all’estero?
Più volte. In Libia intervistai Gheddafi, sotto una tenda berbera. Poi in Tunisia, negli Stati Uniti. La trasferta più toccante in Pakistan per andare a riprendere il corpo senza vita di Maria Grazia Cutuli, la mia collega caduta in Afghanistan. Poi, un mese a Nassiria in Irak, subito dopo la strage di ‘Animal House’ dove morirono 19 italiani e 9 iracheni. La morte ha segnato spesso i giorni della mia carriera. Ho lavorato in una Sicilia dove ho visto cadere per mano mafiosa amici e servitori dello Stato con i quali si era entrati in confidenza. Da Rocco Chinnici, mio padrone di casa nel palazzo della strage di via Pipitone Federico, a Mario Francese, il cronista di giudiziaria del Giornale di Sicilia con il quale dividevamo una scrivania nella redazione di via Lincoln.
Al Corriere della Sera, in via Solferino a Milano, che atmosfera si viveva…
L’emozione che ho provato varcando la prima volta la soglia di via Solferino è come quella che proverebbe un chierichetto entrando per la prima volta in Vaticano. Timoroso, con passi felpati su una spessa stuoia rossa lungo lo scalone che portava al piano nobile, mi ritrovai nella storica Sala Albertini, oggi usata per le riunioni della direzione con i capiservizio, allora luogo in cui si faceva il giornale. Il capo redattore centrale, entrando a destra. Al centro, il mitico tavolo per i redattori delle Cronache italiane. A sinistra, un altro tavolo trasversale per la Politica… Oggi tutto rivoluzionato. Con il web diventato il reparto più affollato.
Quale era il potere del Corriere in quegli anni?
Un direttore del Corriere valeva più di tanti ministri. Un articolo o un commento avrebbe potuto mettere in crisi il governo. Allora dominavano il campo poche famiglie editoriali, come i Rizzoli e gli Agnelli con ‘La Stampa’ di Torino. Erano i potenti che decidevano lo sviluppo del Paese. Non era un caso se si privilegiava il gommato alle linee ferrate. Potenti a volte tentati da avventure vergognose, come quella della P2 che provò a infiltrarsi in via Solferino.
Come ha vissuto l’esperienza milanese?
Milano mi piaceva molto. Mi sentivo vicino all’Europa. Ma non è mancato un momento doloroso, dentro il Corriere.
A che cosa si riferisce esattamente?
Lo scrittore Leonardo Sciascia, che ben conoscevo e frequentavo a Palermo o tornando spesso a Racalmuto, era allora un collaboratore di prima grandezza al Corriere. Autorevole. Quando fu arrestato Enzo Tortora fu lo scrittore di Racalmuto a dare la linea al giornale. Una difesa immediata. Quelle manette furono considerate subito un madornale errore giudiziario da Sciascia. Scrisse un articolo che provocò un grosso dibattito. Come in tante altre occasioni. Ma quando nel 1987 l’acuto polemista siciliano firmò una pagina sui cosiddetti “professionisti dell’antimafia” sottolineando il rischio di trasformare in qualche caso quella lotta nell’esercizio di una impropria forma di potere, scattò una guerra volgare, acida. Molti giornalisti si scagliarono contro Sciascia. Da Pansa a Bocca, da Scalfari ad Arlacchi. Parlarono di un primo e di un secondo Sciascia. Il primo da salvare, il secondo da stracciare. Come fosse stato travolto da una deriva nella critica a giudici antimafia. Non era così. Tanti capirono il valore di quella riflessione oggi considerata profetica alla luce di tante imposture e di molti errori. Ma accadde che, al cambio della direzione, andato via Ostellino e subentrato Ugo Stille, al Corriere della Sera la pubblicazione degli articoli inviati da Sciascia venisse rinviata. Mortificato, a volte ignorato. Fino a quando alla Stampa di Torino non arrivò Gaetano Scardocchia e Sciascia accettò il suo invito a traslocare. Ho vissuto questa storia con disagio e amarezza profonda. Un giorno, salendo lo scalone principale, mi accorsi che dalla parete accanto alla sala Albertini era sparita la foto di Sciascia. Solo dieci anni dopo al giornale capirono l’errore. A Racalmuto organizzai una manifestazione dal titolo: “Il Paese della ragione”. Invitai Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che dissero chiaramente in quella occasione come Sciascia fosse stato malamente interpretato e strumentalizzato anche all’interno della magistratura e del Csm per attaccare una parte dei giudici. Tornò dopo tanti anni quella foto al suo posto, su quella parete fra Buzzati e Montale. Dove per fortuna campeggia ancora.
E’ soddisfatto della sua professione volendo fare un bilancio?
Non bisogna mai sentirsi appagati. So di avere avuto delle soddisfazioni. Ma so che avrei potuto fare di più. E che, avendone tempo, cercherò di realizzare qualche altro progetto. E’ la molla che spinge ad andare avanti.
La mafia e le nuove generazioni…
Noi abbiamo vissuto gli anni dei mille morti di mafia all’anno, fra omicidi, stragi e lupare bianche. Un’apocalisse. La mafia che abbiamo conosciuto noi sembra ormai oggetto di studio. Cosa nostra conta molto meno della mafia calabrese e di altre di spessore internazionale. Ma una certa mentalità mafiosa continua a dilagare, costituendo un pericolo per la democrazia. Se siamo riusciti ad arginarla è accaduto soprattutto grazie ai siciliani che l’hanno combattuta nel loro territorio. Oggi Palermo non è più la capitale della mafia ma dell’antimafia. C’è la mafia, ma non comanda o comanda meno. Anche grazie al lavoro silenzioso che si fa in tante scuole per offrire ai ragazzi gli strumenti di liberazione. Non a caso mi piace sempre richiamare quanto diceva Gesualdo Bufalino, convinto che solo un esercito di maestri potrà davvero sconfiggere la mafia.