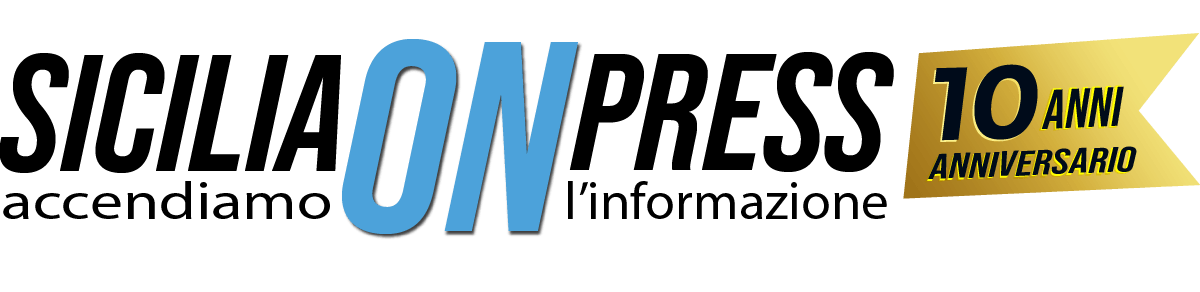di Giuseppe Maurizio Piscopo
C’era un tizio di Favara emigrato a New York che ogni anno ai primi di settembre per la festa di San Giuseppe telefonava al presidente del comitato per avere notizie fresche del paese e chiedeva come stava andando la festa che allora durava sette giorni. L’emigrante non chiudeva la telefonata se prima non sentiva il suono delle campane della chiesa del Rosario. Molti credevano che San Giuseppe fosse il patrono di Favara, invece è Sant’Antonio.
Sette giorni di festa con tre bande musicali, i tammurinara per le strade, il Santo portato in processione con le fanare. La gente aveva negli occhi promesse e desideri, alcune donne facevano il viaggio scalze da casa in chiesa, altre alzavano i loro bambini verso il Santo per una benedizione. Ad ogni persona che faceva un’offerta veniva dato un santino. Maggiore era l’offerta più grande era il santino che rappresentava San Giuseppe con la Madonna e il bambino.
 La festa prima veniva organizzata dai falegnami perché San Giuseppe era un falegname. Il paese si vestiva a festa con i muli bardati carichi di grano che veniva portato accanto alla chiesa del Purgatorio. La luminaria creava un’atmosfera magica di festa, con le luci colorate che restavano accese fino a tardi ed ogni anno nuovi disegni che rimanevano nei ricordi e nel cuore di tutti.
La festa prima veniva organizzata dai falegnami perché San Giuseppe era un falegname. Il paese si vestiva a festa con i muli bardati carichi di grano che veniva portato accanto alla chiesa del Purgatorio. La luminaria creava un’atmosfera magica di festa, con le luci colorate che restavano accese fino a tardi ed ogni anno nuovi disegni che rimanevano nei ricordi e nel cuore di tutti.
A creare quel clima di festa contribuivano le baracche piene di giocattoli, con gli stessi giocattolai che ho rivisto da grande in tutti i paesi della Sicilia e in tutti i giorni di festa.
 Portavano l’odore forte dei dolciumi, dello zucchero filato, dei palloncini, della cubaita, e poi c’erano i venditori popolari di scarpe, di vestiti, di coperte, di utensili per la casa e per la campagna, tutto a buon prezzo. La festa si concludeva con i giochi di fuoco con la maschiata. Un tripudio di suoni, di colori e di luci stampate in cielo. Sette giorni di festa, con la raccolta porta a porta. Per noi bambini la vera festa era il gioco della n’tinna.
Portavano l’odore forte dei dolciumi, dello zucchero filato, dei palloncini, della cubaita, e poi c’erano i venditori popolari di scarpe, di vestiti, di coperte, di utensili per la casa e per la campagna, tutto a buon prezzo. La festa si concludeva con i giochi di fuoco con la maschiata. Un tripudio di suoni, di colori e di luci stampate in cielo. Sette giorni di festa, con la raccolta porta a porta. Per noi bambini la vera festa era il gioco della n’tinna.
 Sin dal mattino in fondo alla piazza, verso il castello, veniva collocato un palo di 10 metri tutto pieno di sapone molle, quello che le nostre mamme usavano per lavare i panni. Per i ragazzi che si cimentavano in questo gioco era facile scivolare.
Sin dal mattino in fondo alla piazza, verso il castello, veniva collocato un palo di 10 metri tutto pieno di sapone molle, quello che le nostre mamme usavano per lavare i panni. Per i ragazzi che si cimentavano in questo gioco era facile scivolare.
Per lo più si vedevano ragazzi poveri e malvestiti, erano quelli che sognavano di prendere i premi che consistevano in salsiccia, formaggi e qualche soldo. Nelle quartare c’erano i soldi spicci e più in alto una banconota. Il gioco della n‘tinna era molto seguito e per alcune ore teneva la folla inchiodata in piazza. Il sapone si scioglieva sui vestiti dei partecipanti che pian piano tentavano di raggiungere il punto più alto del palo per prendere il premio. Spesso per salire si faceva una specie di catena e ognuno saliva sull’altro tenendosi in equilibrio.
 La piazza si trasformava in un circo all’aperto. Per noi bambini quel momento era indimenticabile e il premio rappresentava il sogno più grande. Ognuno di noi avrebbe voluto trovarsi su quel palo che rappresentava la vita con i suoi misteri e i suoi inganni.
La piazza si trasformava in un circo all’aperto. Per noi bambini quel momento era indimenticabile e il premio rappresentava il sogno più grande. Ognuno di noi avrebbe voluto trovarsi su quel palo che rappresentava la vita con i suoi misteri e i suoi inganni.
 Quelli che sentivano maggiormente la nostalgia della festa erano gli emigranti che avevano lasciato Favara alla ricerca di un lavoro in Belgio, in Germania, in Francia, in America. Quando arrivavano i giorni della festa erano assaliti dalla malinconia. Avrebbero voluto dimenticare per sempre quei paesi stranieri, quelle strade dove il cielo è sempre scuro e si parla una lingua che esprime pensieri cupi e lontani che non sono quelli della festa in piazza dove si sta tutti insieme e si vive un momento bello della vita e si dimenticano le meschinità di ogni giorno…
Quelli che sentivano maggiormente la nostalgia della festa erano gli emigranti che avevano lasciato Favara alla ricerca di un lavoro in Belgio, in Germania, in Francia, in America. Quando arrivavano i giorni della festa erano assaliti dalla malinconia. Avrebbero voluto dimenticare per sempre quei paesi stranieri, quelle strade dove il cielo è sempre scuro e si parla una lingua che esprime pensieri cupi e lontani che non sono quelli della festa in piazza dove si sta tutti insieme e si vive un momento bello della vita e si dimenticano le meschinità di ogni giorno…
Ai lettori di Sicilia on Press e ai favaresi nel mondo desidero dedicare una canzone che ho scritto molti anni fa sulla festa.
Pi la festa di San Giuseppi
li picciotti nescinu tutti,
schetti, nichi e maritati
e ci su li cchiù ammucciati.
Nesci la figlia di donna Pippina
lassa la sporta e si metti a vistina,
e lu viddranu finisci i zappari
ca lu vistitu si voli n’cignari.
E c’è la zita ca sta ni cavatu
ca tutta a famiglia appressu ha purtatu
e si lu zitu si voli abbrazzari
puru u signali ci tocca aspittari.
E c’è Nciliddru ca vinni palluna
50 o corpu sennò un vi nni duna,
e li palluna su cchiu unghiati
cu quattro botti l’aviti scattati.
E ni la chiazza la banna ca sona
senti ciauru di turruna,
n’celu volanu li palluna,
forti sparanu li mascuna.
E la ntinna cu lu sapuni
fa sciddricari li persuni,
sempri sempri attorniati,
sempri sempri cchiù scantati.
E li signuri du circulu civili
vidinu l’opra e si piglianu abili,
iddri si sentinu raffinati,
ca a nandru munnu parinu nati.
C’è cu si vonta c’è cu talia
pi cu è zitu è fissaria,
pi cu si voli maritari
megliu mumentu n’un po’ truvari.
Le foto sono di Totò Urso, Lillo Pullara per le foto e Lillo Zarcone.