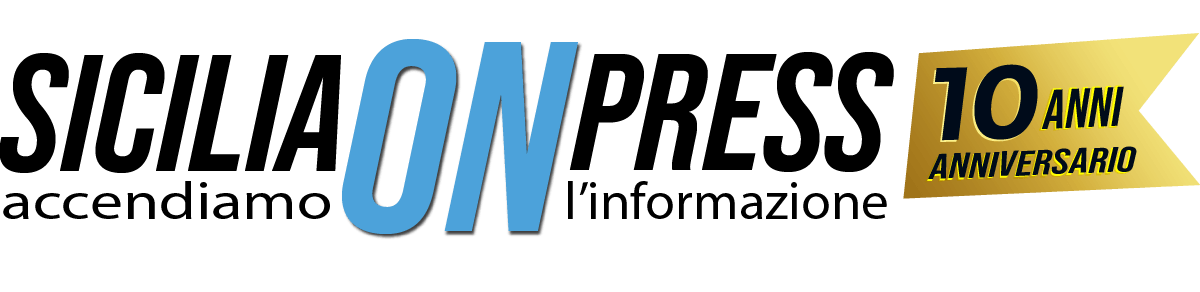Il 21 dicembre scorso papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto che riconosce Rosario Livatino martire della Fede (riconosciuto il suo martirio in odium fidei), aprendo così la strada per la sua beatificazione, programmata per il prossimo 9 maggio presso la Cattedrale di Agrigento.
Il martirio del giudice ragazzino, tuttavia, è stato duplice come emerge da un’intervista di Carmelo Vitello (Ordine Francescano Secolare di Sicilia) a don Giuseppe Livatino, cugino del giudice Rosario Livatino e postulatore della fase diocesana della causa di beatificazione.
Quando, infatti, qualcuno muore per la città, per la polis, si parla di martirio civile e, dunque, nella straordinaria figura di Rosario Livatino i due martirii si fondono in un tutt’uno.

Il giovanissimo magistrato originario di Canicattì, è stato assassinato dalla Stidda, a soli 38 anni, il 21 settembre del 1990 ad Agrigento; era nato – sottolinea Carmelo Vitello- “sotto la buona stella di San Francesco”, ricorrenza che cade il 4 ottobre e, nella sua breve esistenza, ha vissuto una profonda esperienza di fede, riconosciuta dalla Chiesa, sempre coniugandola con un alto senso della giustizia (terrena).
Qualcuno potrebbe domandarsi, ma perché la mafia dovrebbe uccidere un uomo “solo” perché credente? La risposta è molto semplice, “il giudice obbediente” non è stato ucciso, sic et simpliciter per la sua Fede incrollabile, ma per quello che l’autenticità di essa comportava sul piano dell’impegno professionale e sociale di quest’uomo dalla caratura eccezionale: per Rosario Livatino giustizia e carità erano inscindibilmente connesse, egli aveva compreso in pieno il ruolo affidato al laico cristiano: santificarsi e santificare il mondo con la sua testimonianza.
Si riporta integralmente l’intervista a Giuseppe Livatino di Carmelo Vitello, “desideroso di rendere memoria ad un uomo giusto, figlio di questa terra, mentre ci prepariamo a vivere con gioia la beatificazione il prossimo 9 maggio”.
Dove si esprimeva l’“eroismo delle virtù” di Rosario?
Già nei primissimi anni Rosario si occupa di delicate indagini sulle cosche mafiose agrigentine e sui rapporti tra mafia e imprenditoria. Nel 1984, grazie soprattutto alle sue indagini, ad Agrigento si celebra un maxi processo che vede alla sbarra tutti i boss della mafia agrigentina. Da un’indagine su un giro di fatture false fa emergere un intreccio perverso tra politica, mafia e imprenditoria che si concretizza nel voto di scambio. Ha tra le mani una delicata intercettazione telefonica che svela l’intreccio tra le mafie internazionali, e la condivide con Falcone e Borsellino. Continua le indagini del giudice Carlo Palermo sul traffico internazionale di armi, dopo l’attentato di Pizzolungo del 2 aprile 1985. Sono solo pochi esempi del lavoro che Livatino svolge in una terra devastata dal malaffare, dove regna il “familismo”, dove mafia, politica e imprenditoria corrotte riescono a rallentare e talvolta anche a “coinvolgere” nel malaffare pezzi di magistratura. Livatino agisce molto spesso in completa solitudine e in un’atmosfera ostile, ma va ugualmente avanti, anche quando le minacce diventano sempre meno “velate”. Già nel 1984 fa capolino nelle sue agende la consapevolezza circa i pericoli concreti che certamente non tarde- ranno a realizzarsi. Il “giudice ragazzino” va avanti con la sola forza della fede: ogni mattina, prima di entrare al Palazzo di Giustizia, si ferma nella chiesa di San Giuseppe per raccogliersi in preghiera. Nel 1988, a 36 anni, chiede il sacramento della Cresi- ma per affrontare il supremo sacrificio della vita. Rifiuta la scorta con una motivazione “forte”: non vuole coinvolgere padri di famiglia nel suo desti- no. Già colpito a morte, fugge nel vallone ma cade subito a terra. Al killer che sta per sparare i “colpi di grazia” al volto rivolge solo una domanda, in dialetto: «Ragazzi, ma che cosa vi ho fatto?».

Umiltà, riservatezza, rigore professionale, che esempio trovano i magistrati di oggi in Livatino, che sarà il primo magistrato beato della storia della Chiesa?
Nel 1984 tiene una conferenza su: “Il ruolo del giudice nella società che cambia”, che costituisce un trattato di deontologia professionale. Il Martire ci lascia un prezioso testamento con questa e con un’altra conferenza su “Fede e diritto”. Manifesta chiaramente che la professione del magistrato, per la delicatezza del compito a lui affidato, assume una dimensione “sacerdotale”: non si limita ad affermare che il magistrato deve essere indipendente, ma che deve anche apparire tale. Scrive: «È da rigettare l’affermazione secondo la quale, una volta adempiuti con coscienza e scrupolo i propri doveri professionali, il Giudice non ha altri obblighi da rispettare nei confronti della società e dello Stato e secondo la quale, quindi, il Giudice della propria vita privata possa fare, al pari di ogni altro cittadino, quello che vuole». Si dice contrario alle “avventure politiche” del magistrato: «Sarebbe sommamente opportuno che i giudici rinunciassero a partecipare alle competizioni elettorali in veste di candidato o, qualora ritengano che il seggio in Parlamento superi di molto in prestigio, potere ed importanza l’ufficio del Giudice, effettuassero una irrevocabile scelta, bruciandosi tutti i vascelli alle spalle colle dimissioni, definitive, dall’Ordine Giudiziario». Ma il suo ragionamento diventa ancor più chiaro, quando parla dell’appartenenza del magistrato ad associazioni segrete: «Se sono già serie le ragioni di perplessità sulla adesione del Giudice ad un partito politico, queste ragioni appaiono centuplicate nella partecipazione ad organizzazioni di fatto più o meno riservate o, comunque, non facilmente accessibili al controllo dell’opinione pubblica, i cui aderenti risultano fra loro legati da vincoli della cui intensità e natura nessuno è in grado di giudicare e valutare».
Nella responsabilità alta e drammatica che sta sulle spalle di un magistrato, Rosario era attento all’applicazione della legge. Cosa vedeva di fondamentale nell’obbedienza allo Stato? Come la coniugava con l’obbedienza alla Chiesa?
Il ruolo di “giudice” gli era affidato dalla Costituzione, alla quale aveva giurato fedeltà. Del resto, in quanto cristiano, Rosario è consapevole che solo Dio è giudice giusto. E scrive in “Fede e diritto”: «Tale compito sarà tanto più lieve quanto più il magistrato avvertirà con umiltà le proprie debolezze, quanto più si ripresenterà ogni volta alla società – che somma così paurosamente grande di poteri gli affida – disposto e proteso a comprendere l’uomo che ha di fronte e a giudicarlo senza atteggiamento da superuomo, ma anzi con costruttiva contrizione». È illuminante quanto scrive il Martire: «Il peccato è ombra. Per giudicare occorre la luce. E nessun uomo è luce assoluta». Da qui il suo affidamento incondizionato al Signore, il suo “camminare” sub tutela Dei, cioè sotto lo sguardo di Dio.
Giustizia e misericordia. Sono tra loro due sconosciute oppure sono, per Rosario, sorelle gemelle?
Sorelle gemelle, in senso assoluto. Scrive con chiarezza: «Per il cristiano, qualunque rapporto si risolve ed alla fine giustizia e carità combaciano, non soltanto nelle sfere ma anche nell’impulso virtuale e perfino nelle idealità. Il sommo atto di giustizia è necessariamente sommo atto di amore se è giustizia vera, e viceversa».
Il servizio alla città dell’uomo è ciò per cui il giudice Rosario Livatino ha dato la vita. Quale messaggio per i francescani secolari d’Italia e la Chiesa intera?
Il messaggio della coerenza. Il cristiano è realmente, e deve comportarsi come «luce del mondo e sale della terra». Livatino comprende il ruolo affidato al laico cristiano, che è quello di santificarsi e santificare il mondo con la sua testimonianza. Scrive infatti: «il rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione di sé a Dio».