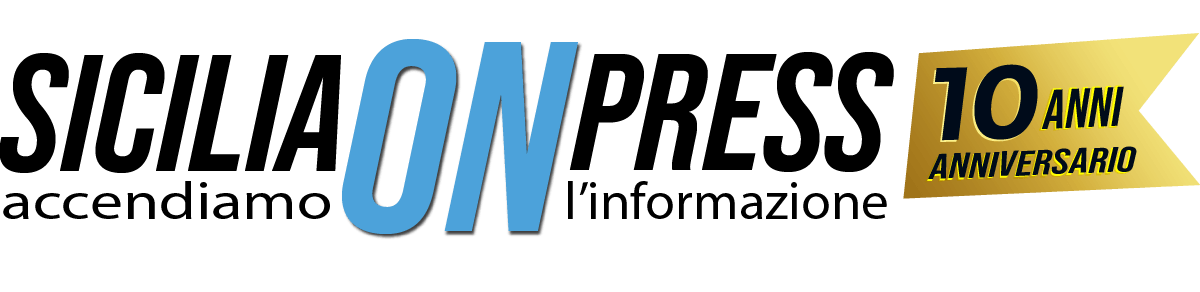di Antonio Patti e Giuseppe Maurizio Piscopo
Un giorno Antonello Bosco mi ha invitato a scrivere una pagina su Gaetano Battaglia e sua moglie Pippineddra per farla conoscere ai favaresi nel mondo. Ho promesso che avrei scritto qualcosa. Per giorni ho pensato una storia, ho cercato di dar forma al negozio di Battaglia, personaggio palermitano e attore felliniano, che fa immediatamente pensare al personaggio di Zampanò nel film La strada . Battaglia si era posizionato a scinnuta da chiazza, nel cortile Mulè.
 Lo stesso cortile dove da bambino ho conosciuto Antonio Patti che allora organizzava spettacoli teatrali per i ragazzi del quartiere. Il mio ricordo di Battaglia è legato al personaggio irrequieto e sorridente, l’uomo dalla battuta sempre pronta, legatissimo alla sua Pippineddra. Quante volte li ho visti partire con la loro moto Guzzi in giro per le feste di paese della provincia con i loro vistosi giocattoli, di legno e di latta, vere opere d’arte che avremmo dovuto conservare nella biblioteca Antonio Mendola o in un museo del giocattolo come quello di Bagheria. Era la Favara della seconda metà degli anni cinquanta piena di luci e di ombre. Antonio Patti descrive la storia di Battaglia con grande poesia, dolcezza ed un finale amaro…
Lo stesso cortile dove da bambino ho conosciuto Antonio Patti che allora organizzava spettacoli teatrali per i ragazzi del quartiere. Il mio ricordo di Battaglia è legato al personaggio irrequieto e sorridente, l’uomo dalla battuta sempre pronta, legatissimo alla sua Pippineddra. Quante volte li ho visti partire con la loro moto Guzzi in giro per le feste di paese della provincia con i loro vistosi giocattoli, di legno e di latta, vere opere d’arte che avremmo dovuto conservare nella biblioteca Antonio Mendola o in un museo del giocattolo come quello di Bagheria. Era la Favara della seconda metà degli anni cinquanta piena di luci e di ombre. Antonio Patti descrive la storia di Battaglia con grande poesia, dolcezza ed un finale amaro…
Un pomeriggio mio padre m’invita, con fare complice, ad andare con lui. Il viaggio è molto più breve di quello che avevo immaginato. Ci fermiamo alla porta accanto, di solito sempre chiusa. In mezzo il portone vecchio e malandato e sempre aperto che porta al primo piano con la sartoria di Carmelo Schifano a sinistra e a destra un patronato, dove apprendo i rudimenti di dattilografia grazie al suo impiegato Antonio Daniele, costretto a usare una sola mano e con una mano soltanto apprendo a digitare con la vecchia Olivetti a doppio carrello; sopra ci stanno l’appartamento di padre Seggio e il nostro. Nella successiva porta c’è la modestissima bottega di Pippineddra Castiddrana, che vende giocattoli artigianali, il bon bon e piccole cianfrusaglie che nessuno, o quasi nessuno, compra più. Di fronte il Caffè Amico, poi nel tempo divenuto Caffè Patti, con una doppia ala di sedie pieghevoli, dove stazionavano dalla mattina alla sera sfaccendati clienti, che nulla o quasi consumavano al banco.
Stranamente questa volta la porta, bassa e con gradini a scendere verso l’interno, è aperta e dentro la stanza semibuia ci sono alcune persone sedute attorno a un piccolo tavolo ed molte altre in piedi. Pippineddra è priata ed è felice. Mai vista così felice prima d’allora. Accanto a lei un uomo di mezza età, segaligno e con una barba ispida di molti giorni. Parla un italiano barbarico e con un fortissimo accento palermitano. Mio padre mi sussurra: «È Tanino Battaglia, suo marito, appena uscito dal collegio». Guardo perplesso Battaglia e guardo mio padre: «Ma non è grande per stare in collegio?» al che si sforza di non ridere e mi fa segno di fare silenzio.
Dove eravamo in quel momento era la loro casa, meglio ancora la loro spelonca. Dall’altra parte c’era il magazzino che dava sul cortile dottore Antonio Mulè. Accanto la loro bottega con il garage della loro tre ruote, una moto Guzzi con un grande cassone dietro.
 Quando partivano, dopo lunghissimi preparativi, Battaglia in groppa alla moto con tanto di giubbotto di pelle e colletto di pelliccia e un paio di occhiali contro la polvere come quelli che anni dopo avrei visto nel gruppo TNT di Alan Ford usati dall’aviatore Otto Grunf. Pippina assisa sul sedile annesso al cassone, con un enorme e vistoso foulard in testa. Il cassone era coperto da un grande telo cerato tenuto fermo da un reticolo di corde. Sotto vi erano i giocattoli, che lui costruiva, e il loro favoloso bombolone, che richiedeva giorni e giorni di lavorazione. Al ritorno il cassone viaggiava carico di vecchie macchine Singer arrugginite raccattate in giro per i paesini della provincia.
Quando partivano, dopo lunghissimi preparativi, Battaglia in groppa alla moto con tanto di giubbotto di pelle e colletto di pelliccia e un paio di occhiali contro la polvere come quelli che anni dopo avrei visto nel gruppo TNT di Alan Ford usati dall’aviatore Otto Grunf. Pippina assisa sul sedile annesso al cassone, con un enorme e vistoso foulard in testa. Il cassone era coperto da un grande telo cerato tenuto fermo da un reticolo di corde. Sotto vi erano i giocattoli, che lui costruiva, e il loro favoloso bombolone, che richiedeva giorni e giorni di lavorazione. Al ritorno il cassone viaggiava carico di vecchie macchine Singer arrugginite raccattate in giro per i paesini della provincia.
Battaglia era, nonostante le apparenze, una persona molto fine e, a suo modo, istruita. Veniva da una famiglia rispettabile di Palermo. Il fratello, si diceva, fosse un maresciallo dei carabinieri. Poi ha conosciuto Pippineddra, se ne era invaghito e lei a poco a poco l’ha fatto diventare quello che ora è: un girovago, un mezzo zingaro. Ogni tanto, specie dopo un bicchiere di troppo, esce fuori il vero Battaglia, con il suo italiano maccheronico e sputasentenze. Proverbiali le sue liti con la moglie, che gli avventori del caffè aspettavano con ansia. Trascorrevano giornate intere a pazientare lì come avvoltoi per farsi quattro risate sulle disgrazie di quei due. Ma non ho capito fino in fondo, anche a distanza di decenni, se queste liti fossero vere o approntate su un canovaccio, più volte collaudato, proprio per far divertire quelle persone e sentirsi, in un modo o nell’altro, accettati, anche loro, nel contesto della vita del paese. In ogni caso i toni venivano esasperati di proposito anche se lo spunto reale c’era quasi sempre per una parola di troppo. Il sospetto mio è che Battaglia e la moglie costruissero giocattoli adatti a tutte le età; parolacce, bestemmie comprese, per i bambini dai capelli grigi o bianchi e giocattoli di latta per i bambini di pochi anni: in effetti i loro alterchi non erano mai banali anche se alcune frasi sono diventate, come si direbbe oggi, dei veri e propri tormentoni, che gli avventori hanno imparato a memoria e trasmesso alle future generazioni.
Tanino, che ho sempre rispettosamente chiamato signor Battaglia, era un genio. Una specie di Leonardo da Vinci dei poveri. Girava per i pochi negozi di allora a farsi regalare o a comprare a buon prezzo le latte di concentrato di pomodoro o di altri prodotti che allora venivano confezionati in barattoli di cinque o dieci chili; sarde salate comprese. Allora non c’erano i barattoli piccoli monodose e monouso di oggi. Il negoziante apriva una lanna di salsa e ci tirava una settimana circa, aggiungendo un po’ di sale o di olio sulla superficie e un foglio di carta oleata o un tulle per proteggere la preziosa merce dalle mosche. I più raffinati mettevano ogni giorno una grande foglia di basilico sopra per attrarre i clienti.
Tanino, quando veniva l’acqua corrente, ogni due settimane all’incirca, lavava tutto con scrupolo nel cortile, le metteva a scolare e ad asciugare e poi si metteva davanti la porta del negozio, sul marciapiede ad angolo tra via Vittorio Emanuele e la discesa via Cesare Battisti, che porta alla piazza principale del paese, a tagliarle. Taglia i due cerchi in alto e in basso e li mette da parte, successivamente taglia la superficie laterale, che spiana sotto una pressa per trasformarla in un lungo foglio rettangolare. Pippina, lì accanto, fa da disattenta ferrista e molti sono gli aneddoti in proposito. Tra le sue mani diventeranno giocattoli. Meravigliosi giocattoli, che rimpiango di non aver conservato perché erano veri e propri gioielli, che poi vendeva a poche lire per sopravvivere. Vere e proprie opere d’arte e d’inventiva: farfalle, che sbattevano le ali e che sembravano che da un momento all’altro dovessero spiccare il volo, pagliacci da circo, che suonavano la grancassa, paladini di Francia che sbattevano con la spada lo scudo e tanti altri ancora; giocattoli per bambine e per bambini. Tutti con il manico di legno, che ricavava da tavole buttate e che lui recuperava. Un meccanismo connesso a una ruota faceva muovere il tutto con rumore e con gioia del piccolo proprietario. Ce ne impiegava di tempo nel fabbricarli. L’immancabile Alfa in bocca, in canottiera anche d’inverno e la bottiglia di vino a calmare il caldo d’estate e il vento gelido d’inverno. E le immancabili bestemmie anch’esse colorite e mai uguali: artista anche in questo.
Il genio si mostrava anche con le vecchie macchine da cucire Singer, che avevano preso il posto dei giocattoli di legno e latta, che ormai nessun bambino voleva più perché c’erano quelli molto più colorati di moplen prima e di plastica dopo. Pure le grosse lanne di latta erano state soppiantate dai piccoli barattoli domestici e la salsa comprata e messa nella carta oleata non la prendeva più nemmeno la casalinga, che comprava a cridenza, segnando su uno sgualcito quaderno la spesa che avrebbe saldato appena il marito sarebbe stato pagato a fine settimana o fine mese.
Macchine che nessuno avrebbe mai immaginato che avrebbero potuto tornare a vivere e funzionare e, molto probabilmente pure meglio di prima tornavano come nuove. Sempre in cortile, in un barile grande di ferro per petrolio o olio per motori, metteva tutti i pezzi a bollire per giorni con la liscivia. Poi una volta sgrassati iniziava la delicata fase di smontaggio dei pezzi. Sempre con la sigaretta accesa in bocca e la bottiglia accanto, seduto su un basso sgabello nell’angolo davanti il Caffè Amico portava avanti questo lavoro di forza e pazienza. Da diverse macchine era capace di rimontarne almeno una perfettamente funzionante. Rifaceva anche le parti in legno, che poi lucidava dando quel tocco di mobile d’antiquariato e dipingeva tutta la struttura metallica. La scritta SINGER in oro o argento, in base al colore in quel momento a disposizione, e invitava solennemente e teatralmente Pippina a cucire qualcosa. La Singer incominciava magicamente a cantare come il suo nome americano impone. Gli altri pezzi li metteva in una grande cassa di legno per la prossima macchina da recuperare.
La moto Guzzi stessa era stata smontata e rimontata diverse volte dal signor Battaglia e partiva sempre alla prima o, al massimo, alla seconda bestemmia. Veniva ora riempita con le macchine Singer da rivendere e si partiva per i paesi della provincia. Moto Guzzi, Tanino e Pippineddra formavano un’unica entità, una trimurti inscindibile e sono rimasti nella rètina dei miei ricordi come il film Sulla strada di Federico Fellini con Battaglia nella parte di Zampanò – Anthony Queen e lei in quella di Gelsomina – Giulietta Masina; la moto Guzzi nella parte del furgone del film stesso. Un film nei miei ricordi di bambino a colori, nella realtà della finzione scenica, in bianco e nero. Umori, caratteri, emozioni, epica della povera gente identici sia nella vicenda umana ed esistenziale dei miei vicini e dei due protagonisti del capolavoro felliniano. E così le vicende delle due coppie nei miei ricordi tendevano lentamente, ma inesorabilmente, a mischiarsi.
Altra specialità di Battaglia e Pippineddra era il bombolone, una caramella di almeno dieci chili che preparavano nell’approssimarsi delle feste e sagre paesane e che scioglievano in un enorme calderone di alluminio con Battaglia intento ad alimentare il fuoco basso di legna e a fare aria per tenere costante la temperatura di fusione dello zucchero e poi a girare con una grande paletta di legno affinché non si attaccasse alle pareti e, soprattutto, sul fondo. Un grande lavoro di braccia, che andavano costantemente oliate con generosi bicchieri di vino. La moglie se ne stava con le braccia a bummolo a controllare che il lavoro, quasi alchemico, procedesse speditamente e senza problemi di sorta. Questa la prima fase. Poi bisognava staccare l’amalgama quasi incandescente, una caramellosa lava, dal cratere di alluminio. A questo punto veniva appallottolata e appesa a un grosso gancio infisso nel muro sempre dentro il cortile Mulè ed iniziava il lavoro, anche questo estenuante, di tirare il più possibile la massa, a farne una forma allungata, poi una treccia e riappendere al gancio per l’altro capo, e si ricominciava a tirare e riappendere fino a che si riempiva di aria, diventasse soffice e si raffreddasse.
Finita questa lavorazione, che durava molte ore anche tenendo presenti le condizioni atmosferiche, iniziava la magica fase del taglio del bombolone trasformato in una lunga striscia. Si tagliavano delle losanghe quasi tutte delle stesse dimensioni e si aspettava che asciugassero completamente. Infine la fase di incartamento con della carta oleata; azzurra per i maschietti e rosa per le bambine. Anche il caramello portava di solito gli stessi due colori, talvolta anche il rosso. Così il bombolone si trasformava in bon bon gustosi e irresistibili. Le condizioni igieniche erano quelle che erano, ma a quei tempi quasi tutti noi bambini eravamo immunizzati. Mia madre mi tirava sempre in casa prima che potessi assaggiare quella leccornia. In ogni caso un passo da gigante rispetto ai ricordi del lungo caramello appeso alla marina di Palermo e descritto mirabilmente dia Fulco di Verdura in Estati felici. Il caramellaro teneva appeso al muro il lungo bombolone e con la sinistra faceva partire il cronometro e con la destra teneva una bacchetta. Il bambino aveva un minuto di tempo per leccare quanto più caramello possibile e iniziava con la lingua a formichiere a leccare avanti e indietro. Al caramellaro il rigoroso controllo che al bambino non venissero in mente furbate come morsi e slinguazzate oltre il fatidico colpo di bacchetta che segnava la fine del pattuito minuto. In caso di bisogno la bacchetta veniva adoperata per dissuadere più o meno energicamente.
Le burnie di vetro venivano riempite con i bon bon e avvolte nelle coperte per evitare che si rompessero durante le loro periodiche peregrinazioni. Le città del mondo, di vittoriniana memoria, erano i paesini dell’entroterra agrigentino e del nisseno. Merce ricercata e forse ancor più dei giocattoli artigianali.
Vita molto dura e sacrificata la loro, costretti a vivere e a ripararsi dai temporali e dal freddo sotto la cerata, abbracciati per sentire meno freddo avendo per giaciglio qualche sacco di riso. Eppure mi sono sembrati sempre affiatati. Per anni hanno condotto questa vita.
La signora Battaglia un giorno mi ha fatto entrare nella loro casa, nella stanza dove ho visto per la prima volta Tanino e mi ha aperto degli scatoloni di cartoni tirando fuori un oggetto avvolto delicatamente dalla carta bianca e morbida d’imballaggio di oggetti fragili e mi mostra un servizio di piatti nuovo, mai usato. Poi mi indica altri scatoli e mi dice che in quello c’era un servizio di caffè, un altro con un servizio da tè, posate e altro. «Un giorno, appena ci fermiamo, metteremo ordine a questa casa e avrò la casa come tutti. Ho tutti i miei sacrifici conservati in questi scatoli. Mi farò una bellissima stanza da pranzo con una cristalliera e lì tutti questi servizi saranno esposti per quando avremo degli ospiti di riguardo». Le lucevano gli occhi per l’emozione, si vedeva già in quella casa, orgogliosa di mostrare tutti quei gioielli luccicanti. «Non lo dire a nessuno sennò mi rubano tutto. Di te mi fido perché sei un bravo ragazzo».
Non hanno fatto in tempo a realizzare questo sogno.
Da uno dei tanti viaggi Tanino era tornato astemio, non bestemmiava più e nemmeno diceva più una mezza parolaccia. Sembrava un’altra persona. Più smagrito e con gli occhi su un altro mondo, su un’altra realtà.
Aveva visto il Demonio sotto forma di un animale, che cambiava continuamente forma. Correva accanto a lui. Tanino lanciava alla massima velocità la sua moto Guzzi, ma quello sempre accanto; ora cane con zanne lunghe e affilate come un cinghiale inferocito a guardarlo minaccioso, ora una grottesca scimmia e lui a gridare. Anche Pippina finì con il vedere e sentire il diavolo, a sentirne pure la puzza insopportabile. Scene terrificanti, una notte senza luna e senza stelle a correre col rischio di andare fuori strada e sfracellarsi contro un muro, un albero o in un dirupo. E il demonio sempre al fianco di Tanino. Pippina incomincia a pregare, le ritornano le preghiere apprese da bambina e invita pure Battaglia e pregare, a chiedere perdono a Dio per tutte le bestemmie, per tutte le cose brutte che il vino e la miseria gli avevano istigato. Soltanto con le preghiere a poco a poco Satana perde velocità e finalmente diventa un puntino sempre più indistinguibile.
Tornano a casa definitivamente. Tanino non beve più, ma ogni tanto i mostri tornano a tormentarlo durante il sonno, ma anche durante la veglia. Anni dopo, studiando psichiatria, apprenderò l’esistenza della Sindrome di Rimsky – Korsakoff, che non è il musicista, ma sono medici che hanno descritto questa forma di pazzia caratterizzata da visioni terrifiche di mostri in soggetti alcolizzati. Una bruttissima fine per una persona sostanzialmente buona e affabile con noi bambini del vicinato e che ci aiutava sempre nell’aggiustare qualcosa. In quegli anni anche un altro personaggio del mio paese aveva avuto, proprio nello stesso periodo e per l’alcolismo cronico, analoghe visioni di mostri. Battaglia e Amaddì hanno poi ispirato il mio libro Bestiario favarese, in gran parte ancora inedito.
Il resto si perde nella confusa memoria di un distacco dovuto al fatto che nel frattempo, crescendo, avevo meno tempo per stare nel cortile Mulè perché gli studi mi portarono prima ad Agrigento e poi a Palermo. La Palermo da cui Battaglia aveva iniziato la sua descensus Averno, la Favara degli anni Cinquanta e Sessanta.