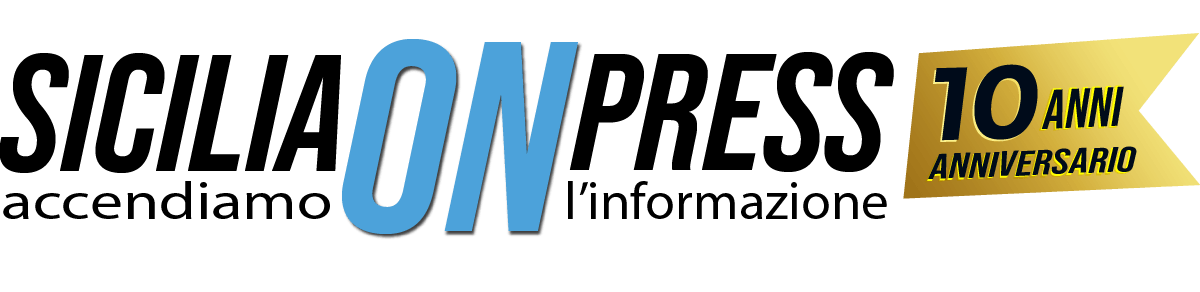Giuseppe Maurizio Piscopo
La sera della vigilia i bambini andavano a letto con un po’ di paura, ma con tante attese, perché si diceva loro che i defunti, i nonni in particolare sarebbero venuti nottetempo in casa a lasciare loro i giocattoli e i dolciumi. E i bambini che hanno avuto una gran fretta di addormentarsi con la testa sotto le coperte, si svegliavano prestissimo per andare a cercare e a scoprire ciò che è stato portato loro per vie misteriose. I genitori mettevano su un tavolo in grande evidenza “ una pupa di cena”, una statuetta di zucchero rappresentante un paladino di Francia e anche un bersagliere, una ballerina o altri personaggi vicini alla fantasia infantile. Attorno ad essa tanta pasta reale, pasta di mandorle con la forma e i colori della frutta. E poi molti biscotti col cimino e i “cuddureddri” a forma di ruota con velata di zucchero. E poi i giocattoli: piccoli paladini, carrettini siciliani, fucili, pistole, spade di latta e altri giochi con le batterie. C’erano anche i genitori bontemponi che inventavano cari estinti burloni, e deludevano i bambini che trovavano vuoto il tavolo del tinello ed erano costretti a cercare i doni in ogni angolo della casa, anche in quelli più nascosti e più impensabili. Cercavano nel sottoscala, sotto il letto. Questa favola ancora sussiste negli ambienti e nei quartieri popolari con lo stesso cerimoniale.
E poi i giocattoli: piccoli paladini, carrettini siciliani, fucili, pistole, spade di latta e altri giochi con le batterie. C’erano anche i genitori bontemponi che inventavano cari estinti burloni, e deludevano i bambini che trovavano vuoto il tavolo del tinello ed erano costretti a cercare i doni in ogni angolo della casa, anche in quelli più nascosti e più impensabili. Cercavano nel sottoscala, sotto il letto. Questa favola ancora sussiste negli ambienti e nei quartieri popolari con lo stesso cerimoniale. A Palermo nei mercati di Palermo per la festa dei morti ho visto con i miei occhi che tra i giocattoli spiccavano pistole e fucili a piombini e in vicolo del Pallone o a piazza dello spasimo i bambini giocavano gridando e mostravano agli altri bambini i loro nuovi giocattoli. Ho un triste ricordo in questa giornata. Alcuni miei compagni mi hanno svegliato di buona mattino. I morti avevano fatto trovare pistole e fucili a piombini, uno di loro venne colpito in un occhio e quella che doveva essere una bella festa si trasformò in tragedia e il mio compagno finì al San Giovanni di Dio di Agrigento con il rischio di perdere l’occhio. Ma la festa dei morti per noi bambini era più importante del Natale e l’accoglievamo cantando così:
A Palermo nei mercati di Palermo per la festa dei morti ho visto con i miei occhi che tra i giocattoli spiccavano pistole e fucili a piombini e in vicolo del Pallone o a piazza dello spasimo i bambini giocavano gridando e mostravano agli altri bambini i loro nuovi giocattoli. Ho un triste ricordo in questa giornata. Alcuni miei compagni mi hanno svegliato di buona mattino. I morti avevano fatto trovare pistole e fucili a piombini, uno di loro venne colpito in un occhio e quella che doveva essere una bella festa si trasformò in tragedia e il mio compagno finì al San Giovanni di Dio di Agrigento con il rischio di perdere l’occhio. Ma la festa dei morti per noi bambini era più importante del Natale e l’accoglievamo cantando così:
“Tale chi ni ficiru acchiari i morti
u pupu cu l’anchi torti,
a gatta ca sunava,
u surci chi abballava
veni la zita
cu a vesta di sita
veni u baruni
chi causi a pinnuluni”…
Racconta l’attore Salvo Piparo,- “Il primo e il due novembre a Palermo c’era la fiera dei morti ed io ci andavo sempre con mio nonno. In un angolo c’era un banco strapieno di cannistri ceste pieni di leccornie, tetu, catalani, ossa di morti, scorci d’ova, rattuli, castagne, una quantità enorme di biscotti con al centro la pupa di zucchero di tanti colori, il cannistru con Orlando aveva il pennacchio verde, quello di Rinaldo aveva il pennacchio grosso e rosso. Rinaldo era conosciuto nella tradizione comu u fimminaru, il pennacchio di Astolfo di Inghilterra era azzurro. C’era u cannistru della bella principessa a beddra pupa a cena comu u culuri di a gattareddra Angelica. Che tristezza quando le pupe di zucchero sono diventatati i Pokemon, i Simpson e Peppa Pig! In un banco al mercato del Capo di Palermo c’era il re delle panelle, il palermitano Nino ballerinu pure lui di zucchero. Con il tempo che passa qualcuno ha tentato di rubarci le tradizioni e le nostre belle storie… sostituendole con la festa di Halloween. Desidero concludere questo momento della nostra vita con una pagina nel ricordo di Andrea Camilleri.
“Fino al 1943, nella nottata che passava tra il primo e il due di novembre, ogni casa siciliana dove c’era un picciliddro si popolava di morti a lui familiari.
Non fantasmi col linzòlo bianco e con lo scrùscio di catene, si badi bene, non quelli che fanno spavento, ma tali e quali si vedevano nelle fotografie esposte in salotto, consunti, il mezzo sorriso d’occasione stampato sulla faccia, il vestito buono stirato a regola d’arte, non facevano nessuna differenza coi vivi. Noi nicareddri, prima di andarci a coricare, mettevamo sotto il letto un cesto di vimini (la grandezza variava a seconda dei soldi che c’erano in famiglia), che nottetempo i cari morti avrebbero riempito di dolci e di regali che avremmo trovato il 2 mattina, al risveglio.
Eccitati, sudatizzi, faticavamo a pigliare sonno: volevamo vederli, i nostri morti, mentre con passo leggero venivano al letto, ci facevano una carezza, si calavano a pigliare il cesto. Dopo un sonno agitato ci svegliavamo all’alba per andare alla cerca. Perché i morti avevano voglia di giocare con noi, di darci spasso, e perciò il cesto non lo rimettevano dove l’avevano trovato, ma andavano a nasconderlo accuratamente, bisognava cercarlo casa casa. Mai più riproverò il batticuore della trovatura quando sopra un armadio o darrè una porta scoprivo il cesto stracolmo. I giocattoli erano trenini di latta, automobiline di legno, bambole di pezza, cubi di legno che formavano paesaggi. Avevo 8 anni quando nonno Giuseppe, lungamente supplicato nelle mie preghiere, mi portò dall’aldilà il mitico Meccano e per la felicità mi scoppiò qualche linea di febbre.
I dolci erano quelli rituali, detti “dei morti”: marzapane modellato e dipinto da sembrare frutta, “rami di meli” fatti di farina e miele, “mustazzola” di vino cotto e altre delizie come viscotti regina, tetù, carcagnette. Non mancava mai il “pupo di zucchero” che in genere raffigurava un bersagliere e con la tromba in bocca o una coloratissima ballerina in un passo di danza. A un certo momento della mattinata, pettinati e col vestito in ordine, andavamo con la famiglia al camposanto a salutare e a ringraziare i morti. Per noi picciliddri era una festa, sciamavamo lungo i viottoli per incontrarci con gli amici, i compagni di scuola: «Che ti portarono quest’anno i morti?». Domanda che non facemmo a Tatuzzo Prestìa, che aveva la nostra età precisa, quel 2 novembre quando lo vedemmo ritto e composto davanti alla tomba di suo padre, scomparso l’anno prima, mentre reggeva il manubrio di uno sparluccicante triciclo.
Insomma il 2 di novembre ricambiavamo la visita che i morti ci avevano fatto il giorno avanti: non era un rito, ma un’affettuosa consuetudine. Poi, nel 1943, con i soldati americani arrivò macari l’albero di Natale e lentamente, anno appresso anno, i morti persero la strada che li portava nelle case dove li aspettavano, felici e svegli fino allo spàsimo, i figli o i figli dei figli. Peccato. Avevamo perduto la possibilità di toccare con mano, materialmente, quel filo che lega la nostra storia personale a quella di chi ci aveva preceduto e “stampato”, come in questi ultimi anni ci hanno spiegato gli scienziati. Mentre oggi quel filo lo si può indovinare solo attraverso un microscopio fantascientifico. E così diventiamo più poveri: Montaigne ha scritto che la meditazione sulla morte è meditazione sulla libertà, perché chi ha appreso a morire ha disimparato a servire”.
(da Racconti quotidiani di Andrea Camilleri).
Si ringraziano Salvatore Indelicato per le foto e il pittore Vincenzo Roberto Gatto per un suo dipinto.