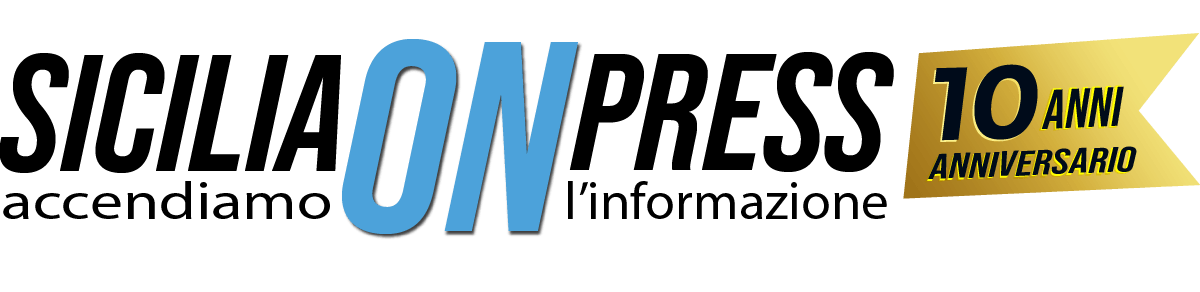Patrocinante legale
Addio abiti “troppo” succinti in occasione di appuntamenti intriganti o serate di gala… per la Cassazione chi li indossa in luogo pubblico commette reato!
Di tale indirizzo è la recentissima pronuncia della Corte, che è stata chiamata a pronunciarsi su un caso concreto piuttosto singolare, a tal punto, da dover prendere una decisione controversa che oscilla tra il comune senso del pudore ed il moralismo.
Coinvolta nel caso è una donna che, passeggiando in pieno giorno per le vie di Bologna, viene sorpresa da un uomo delle forze dell’ordine vestita sì, ma, a giudizio di quest’ultimo, neanche troppo.
Dunque, accusata di essere abbigliata in modo da scoprire eccessivamente le parti intime del corpo, in particolare il seno ed il fondoschiena, viene sanzionata con una multa, avverso la quale la malcapitata ricorre al Giudice di Pace di Bologna, che, tuttavia, ritenendo la sua condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 726 del Codice penale, in quanto offensiva del comune sentimento del pudore, le conferma l’ammenda di ottocento euro comminatale.
La donna decide quindi di ricorrere alla Suprema Corte perchè, contestando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato a lei ascritto, assume di avere tenuto un comportamento non in contrasto con i valori sociali di riferimento e relativi alla costumatezza dell’abbigliamento, e, conseguentemente, chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
La Terza Sezione Penale, però, ritenendo integrati, nel caso de quo, gli elementi costitutivi dell’ipotesi contravvenzionale di atti contrari alla pubblica decenza, prevista dal citato art. 726 C. P., rigetta il ricorso e condanna la donna anche al pagamento delle spese processuali.
Ad avviso dei giudici, infatti, “La tipicità del reato in contestazione consiste nel porre in essere atti contrari alla pubblica decenza”, cioè “quegli atti che, in se stessi o a causa delle circostanze, rivestono un significato contrario alla pubblica decenza, assunti in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico”.
Secondo la Cassazione, dunque, è giusto condannare la donna “vista la gravità della condotta, l'insensibilità della prevenuta all'offesa arrecata alla collettività, comprovante il suo completo disinteresse alle interferenze negative che il suo comportamento avrebbe potuto determinare al comune vivere civile”.
Per la Suprema Corte, questo tipo di atteggiamento non può essere considerato un fatto lieve, né assume alcuna importanza se i passanti si siano, o meno, accorti della circostanza che la ragazza fosse particolarmente “scoperta” in alcune parti, stante che, affinchè sussista il reato di cui all’articolo 726 del Codice Penale, vale a dire “porre in essere atti contrari alla pubblica decenza”, “non rileva che detti atti siano percepiti da terzi essendo sufficiente la mera possibilità della percezione di essi, in quanto l’articolo 726 cp tutela i criteri di convivenza e decoro che, se non osservati e rispettati, provocano disgusto e disapprovazione”.
In verità, la Corte è stata chiamata a giudicare su un tema alquanto controverso e di difficile valutazione se si prova a riflettere che su quale sia il confine della pubblica decenza e sui criteri astratti a cui ispirarsi per la valutazione di un atteggiamento rispetto ad un altro.
Si tratta di una sentenza sicuramente destinata a far discutere perché interviene su un campo molto delicato, quello dell’etica e della morale, motivo per cui, a commento della stessa, scendono in campo, da un lato i moralisti benpensanti, che esultano di gioia per la condanna di una “spudorata” che se ne andava per la città ledendo impunemente la pubblica decenza, dall’altro i libertari e gli anarchici, che, invece, indignano sostenendo che nessuno può essere discriminato per il proprio abbigliamento, che in ultima analisi è espressione del proprio modo di essere: “Ognuno ha il diritto di vestirsi come vuole”.
Per di più, sono già in molti a sostenere che si tratti di un giudizio che incide negativamente sulla libertà della donna di abbigliarsi nel rispetto della sua persona e della gestione del proprio corpo.
Infatti, se è vero che “è vietato dare spettacolo”, risulta altrettanto pacifico che, allo stesso tempo, non siano molti i divieti posti nel mondo dello spettacolo per vietare l’uso strumentale e a fini commerciali del corpo femminile, quasi che insomma passi usare il corpo delle donne come strumento per vendere di più e per fare più share in televisione, ma per nessuna ragione può essere gestito dalle donne stesse.
Dunque, è necessario porsi un interrogativo: perché i giudici perseguono le donne discinte per strada e non quelle che appaiono tali, o anche peggio, in televisione?
Una contraddizione che evidentemente dimostra come la buona vecchia Italia, ancora una volta, rispetto all’Europa si fermi un passo indietro per quel riguarda l’emancipazione femminile anche sul piano dell’abbigliamento e della gestione del proprio corpo.
Esiste una via d’uscita o un metro di giudizio che permetta di valutare un punto di equilibrio tra libertà e idea di decenza condivisa?
In definitiva, si sarà costretti a stabilire per legge il numero dei centimetri minimi a cui le sartorie devono attenersi e che le donne devono misurare prima di uscire di casa?
Certamente la Jessica Rabbit condannata in questione avrebbe fatto meglio a spendere gli ottocento euro, l’ammontare della multa pagata, per acquistare qualche centimetro di stoffa in più!